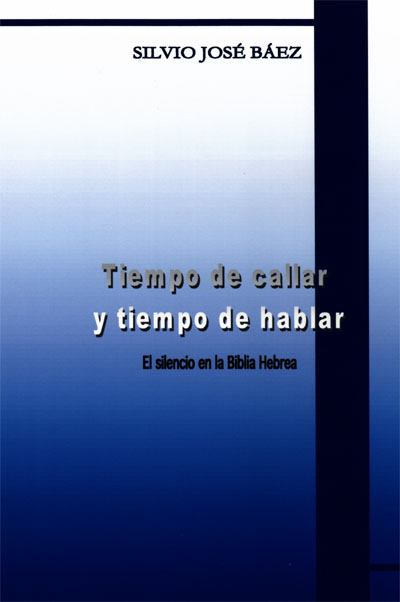DOMENICA
DI PENTECOSTE
DOMENICA
DI PENTECOSTE
(Ciclo B)
![]()
At 2, 1-11
Gal 5,16,25
Gv 15,26-27; 16,12-15
Lo
Spirito è la stessa vita di Dio. Nella Bibbia è sinonimo di vitalità, di
dinamismo e di novità. Lo Spirito animò la missione di Gesù e si trova anche
alla base della missione della Chiesa. L’evento della Pentecoste ci fa risalire
al cuore stesso dell’esperienza cristiana ed ecclesiale: una esperienza di vita
nuova con dimensioni universali.
La prima lettura
(At 2, 1-11), è il racconto di Pentecoste:
in esso si narra il compimento della promessa fatta da Gesù alla fine del
vangelo di Luca: “E io manderò su di voi quello che il Padre mio ha
promesso…restate in città, finché non siate rivestiti di potenza dall’alto” (Lc
24, 49); e all’inizio del libro degli Atti: “…voi sarete battezzati in Spirito
Santo, fra non molti giorni…avrete forza dallo Spirito Santo” (At 1,5.8). Con
questo racconto, Luca approfondisce un aspetto fondamentale del mistero
pasquale: Gesù risorto ha inviato lo Spirito Santo alla comunità nascente,
rendendola capace di una missione con un orizzonte universale. L’effusione
dello Spirito a Pentecoste, in effetti, segna l’inizio della missione della
Chiesa, nello stesso modo in cui il battesimo di Gesù indica l’inizio della
vita pubblica del Signore. In ambedue i casi si parla di una “discesa” dello Spirito:
“E scese su di lui lo Spirito Santo in apparenza corporea, come di colomba” (Lc
3,22; cf. At 2, 3); lo spirito si dona per la missione: “Lo Spirito del Signore
è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione, e mi ha mandato ad
annunziare ai poveri un lieto messaggio” (Lc 4, 18; cf. At 2, 14-41), e in tutte
e due le occasioni la discesa dello Spirito conclude un periodo di preparazione
ed inaugura quello dell’attività pubblica (cf. Lc 4, 14-15).
Il racconto di Lc 2 inizia dando alcune indicazioni relative al tempo,
al luogo e alle persone implicate nell’evento. Tutto succede “mentre il giorno
di Pentecoste stava per finire” (At 2, 1). Pentecoste è una festa
conosciuta come “festa delle settimane”
(Es 34, 22; Nm 28, 26; Dt 16, 10,16; ecc.) o “festa della mietitura” (Es 23,
16; Nm 28, 26; ecc.), che si celebrava sette settimane dopo la Pasqua. Sembra
che in alcuni ambienti giudei, in epoca tarda, in occasione di questa festa si
celebrassero le grandi alleanze di Dio con il suo popolo, particolarmente
quella del Sinai, legata al dono della Legge. Anche se Luca non sviluppa questa
tematica nel racconto di Pentecoste, conosceva sicuramente questa tradizione ed
è probabile che abbia voluto associare il dono dello Spirito, inviato da Cristo
risorto, al dono della Legge ricevuto sul Sinai. Nella comunità di Qumràn,
contemporanea a Gesù, per esempio, Pentecoste era arrivata ad essere
considerata la festa della Nuova Alleanza che assicurava l’effusione dello
Spirito di Dio al nuovo popolo purificato (cf. Ger 31, 31-34, Ez 36). Luca
aggiunge: “si trovavano tutti insieme nello stesso luogo” (At 2, 1). Con questa
indicazione egli vuole suggerire che i presenti stanno uniti non solo in uno
stesso luogo ma con il cuore. Anche se non si parla di riunione cultuale, non
sarebbe strano che Luca immagini i credenti in preghiera, aspettando la venuta
dello Spirito, così come Gesù stava pregando quando lo Spirito scese su di lui
in occasione del suo battesimo (Lc 3, 21: “Mentre Gesù pregava… lo Spirito
scese su di lui”; At 1, 14: “Tutti questi erano assidui e concordi nella
preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù e con i
fratelli di lui”).
“Venne
all’improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbate gagliardo, e
riempì tutta la casa dove si trovavano” (At 2, 2). Nonostante i discepoli
stessero aspettando il compimento della promessa del Signore risorto, l’evento
accade “all’improvviso” e, per tanto in forma imprevedibile e repentina. E’
questa una forma per sottolineare che si tratta di una manifestazione divina,
visto che l’attuare di Dio non può essere calcolato né previsto dall’uomo. Il “rombo”
arriva “dal cielo”, cioè, dal luogo della trascendenza, da Dio. La sua origine
è divina. Ed è come il rumore di una raffica di vento impetuoso. L’evangelista
vuole descrivere la discesa dello Spirito santo come potere, come potenza e
dinamismo, e, per tanto, il vento era un elemento cosmico adeguato per
esprimerlo. In più, tanto in ebraico come in greco, spirito e vento si
esprimono con la stessa parola (ebraico: ruah;
greco: pneuma). Non è strano per
tanto che il vento sia uno dei simboli biblici dello Spirito. Basta pensare al
gesto di Gesù nel vangelo di oggi, quando “soffia” sui discepoli e dice loro:
“Ricevete lo Spirito Santo” (Gv 20, 22), o alla visone delle ossa inaridite,
narrata in Ez 37, dove il vento – Spirito di Dio fa che queste ossa si
rivestino di nervi e di carne, ricreando il nuovo popolo di Dio.
“Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su
ciascuno di loro” (At 2, 3). Luca si serve di un altro elemento cosmico che era
utilizzato frequentemente per descrivere le manifestazioni divine nell’Antico
Testamento: il fuoco, che è simbolo di Dio come forza irresistibile e
trascendente. La Bibbia parla di Dio come di un “fuoco divoratore” (Dt 4, 24;
Is 30, 27; 33, 14); “fiamme perenni” (Is 33, 14). Tutto ciò che entra in
contatto con lui, come succede con il fuoco, si trasforma. Il fuoco è anche
espressione del mistero della trascendenza divina. In effetti, l’uomo non può
mantenere il fuoco tra le sue mani, li sfugge sempre; e, comunque, il fuoco lo
riveste della sua luce e lo conforta con il suo calore. Così è lo Spirito:
poderoso, irresistibile, trascendente.
L’evento straordinario espresso simbolicamente nei vv. 2-3, si
esplicita nel v. 4: “furono tutti pieni di Spirito Santo…”. Dio stesso riempie
con il suo potere tutti i presenti. Non viene comunicato loro un aiuto
qualsiasi, ma la pienezza del potere divino che nella Bibbia si identifica con
quella stessa realtà che si chiama: lo Spirito. Si tratta di un evento unico
che segna l’avvento dei tempi messianici e che permarrà per sempre nel cuore
stesso della Chiesa. Da questo momento in poi, lo Spirito sarà una presenza
dinamica e visibile nella vita e nella missione della comunità cristiana. “…e
cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di
esprimersi” (v.4). La forza interiore e trasformatrice dello Spirito, descritta
precedentemente con i simboli del vento e del fuoco, diventa ora capacità di
comunicazione che inaugura l’eliminazione dell’antica divisione tra gli uomini,
a causa della confusione delle lingue di Babele (Gn 11). A Gerusalemme, non
nella casa dove stanno i discepoli, non nello spazio chiuso di pochi eletti, ma
nello spazio aperto dove c’è gente di tutte le nazioni (v.5), in piazza e nella
strada, lo Spirito ricostruisce l’unità dell’umanità intera ed inaugura la
missione universale della Chiesa. Il peccato condannato nel racconto della
torre di Babele è la preoccupazione egoistica degli uomini che si chiudono e
non accettano l’esistenza di altri gruppi e altre società, e desiderano invece
restare uniti intorno ad una grande città la cui torre tocchi il cielo. Il
giorno di Pentecoste lo Spirito è venuto a perdonare e a rinnovare gli uomini
affinché non si ripetano più le tragedie causate dal razzismo, dalla chiusura
etnica e dagli integralismi religiosi. Lo Spirito di Pentecoste inaugura una
nuova esperienza religiosa nella storia dell’umanità: la missione universale
della Chiesa. La Parola di Dio, grazia alla forza dello Spirito, sarà
pronunciata lungo la storia in diverse lingue e sarà incarnata in tutte le
culture. Il giorno di Pentecoste, la gente venuta da tutte le parti della terra
“li sentiva parlare la propria lingua” (At 2, 6.8). Il dono dello Spirito che
la Chiesa riceve, all’inizio della sua missione, la rende capace di parlare con
una forma intelligibile a tutti i popoli della terra.
sentiva parlare la propria lingua” (At 2, 6.8). Il dono dello Spirito che
la Chiesa riceve, all’inizio della sua missione, la rende capace di parlare con
una forma intelligibile a tutti i popoli della terra.
La seconda lettura
(Gal 5,16,25) descrive la nuova situazione dell’uomo
che vive “in Cristo”, come una vita segnata dalla libertà nei confronti della
carne (“istinti egoistici”) e della legge (“ogni azione coattiva e ogni norma
esteriore”). L’etica cristiana, responsabile e libera, è radicata nella
docilità allo Spirito, che è vita e amore. E’ una vita in libertà, che non è
dominata né dalla carne, né da alcuna legge. Un’esistenza al servizio dell’amore.
Una libertà che si conserva facendosi guidare interiormente in ogni momento dalla
forza e dalla grazia dello Spirito. Ciò che richiede la legge diventa
obbligazione e carico pesante, ciò che nasce dallo Spirito diventa il modo
naturale e spontaneo d’agire. Le opere della carne e il frutto dello Spirito
non sono un semplice catalogo di vizi e virtù, ma alcuni esempi che descrivono
le conseguenze intrinseche e visibili di due modi opposti di orientare la
propria vita. Anche se le tendenze della carne accompagneranno sempre l’essere
umano, Paolo ricorda che è possibile “crocifiggere” la carne con i suoi desideri
e le sue passioni; cioè, fare che Cristo e lo Spirito diventino il principio
dinamico e orientativo di tutta l’esistenza.
Il vangelo (Gv 15,26-27; 16,12-15) è costituito da due testi del vangelo di Giovanni. (a) Gv 15,26-27: afferma che lo Spirito darà testimonianza di Gesù; in primo luogo, rendendo capaci i discepoli stessi di capire ed accettare personalmente il senso della loro esistenza e della loro missione alla luce di Cristo; in secondo luogo, rafforzandoli per essere testimoni di fronte al mondo. (b) Gv 16, 12-15: si riferisce allo Spirito come difensore (“paraclito”) e come maestro, chiamandolo “spirito di verità”. La verità è la parola di Gesù e lo Spirito si presenta con la missione “di condurre alla verità tutta intera”, aiutare cioè i discepoli a comprendere tutto ciò che è stato detto insegnato da Gesù nel passato, facendo che la sua parola sia sempre viva ed efficace, capace di illuminare, in ogni situazione storica, la vita e la missione dei discepoli.
NUOVO LIBRO
Silvio José Báez, OCD, Tiempo de callar y tiempo de hablar. El silencio en la Biblia Hebrea, ediciones del Teresianum, Roma 2000.